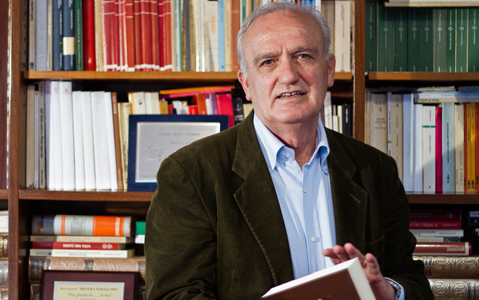 Conoscevo Giovanni Caserta come storico e critico letterario di grande valore. Il primo libro avuto tra le mani è La triste storia di Isabella Morra (su cui stavo scrivendo un’opera di teatro), poi la Storia della letteratura lucana e via via le altre opere, che ho letto sempre più convincendomi che si tratta di lavori scritti con serietà assoluta. Caserta è uno di quegli studiosi che non trascurano nulla prima di occuparsi di un tema o di un personaggio; fa le indagini più accurate e le più attente valutazioni e soltanto dopo si accinge a mettere mano ai lavori. E’ per questo che i suoi libri risultano precisi e accattivanti, compresi la Guida di Matera e il profilo di Parrella, per non parlare degli studi danteschi. Oggi la sorpresa di scoprirlo narratore! E che narratore! Di quelli che riescono a portare il lettore dentro le atmosfere, creando un rapporto di complicità con i personaggi e con il paesaggio, con le loro storie e le loro situazioni sociali e umane.
Conoscevo Giovanni Caserta come storico e critico letterario di grande valore. Il primo libro avuto tra le mani è La triste storia di Isabella Morra (su cui stavo scrivendo un’opera di teatro), poi la Storia della letteratura lucana e via via le altre opere, che ho letto sempre più convincendomi che si tratta di lavori scritti con serietà assoluta. Caserta è uno di quegli studiosi che non trascurano nulla prima di occuparsi di un tema o di un personaggio; fa le indagini più accurate e le più attente valutazioni e soltanto dopo si accinge a mettere mano ai lavori. E’ per questo che i suoi libri risultano precisi e accattivanti, compresi la Guida di Matera e il profilo di Parrella, per non parlare degli studi danteschi. Oggi la sorpresa di scoprirlo narratore! E che narratore! Di quelli che riescono a portare il lettore dentro le atmosfere, creando un rapporto di complicità con i personaggi e con il paesaggio, con le loro storie e le loro situazioni sociali e umane.
Lettere provinciali, titolo già adoperato da Pascal, non sono saggi di filosofia, ma racconti, esattamente undici, il primo dei quali molto lungo, tanto da poterlo configurare come romanzo breve. Piace che Caserta si faccia introdurre da un pensiero di Novalis (“Frammenti così sono semine di pensieri. Potranno certo esservi molti granelli sterili; purché ne germogli qualcuno!”) e da un altro di Giorgio Bassani (“I morti da poco sono più vicini a noi, e appunto per questo gli vogliamo più bene”). Giustifica qundi il suo sconfinamento nel campo della narrazione, anche se veniamo a sapere che il suo sogno, fin da giovane, era proprio questo. Del resto non mancano nella storia della letteratura italiana esempi clamorosi di critici come De Sanctis, Borgese e Croce, per fare soltanto alcuni esempi, che hanno realizzato opere narrative di grande rilievo, come Il viaggio elettorale, La giovinezza, il Rubè e Le storie napoletane.
Il primo e il più lungo dei racconti, Sulla strada di Jesce, si svolge tra Stoccarda e Matera in pieno clima di emigrazione massiccia. E Caserta è bravissimo nel portare tutte le angosce di Francesco, l’operaio che emigra in Germania, nel clima di un discorso generale che, negli anni Cinquanta-Sessanta, sconquassò ambienti, famiglie, stati sociali di intere comunità. Certo, di romanzi e racconti che narrano le storie degli emigranti e le loro difficoltà dinanzi a civiltà diverse, a lingue diverse, ad abitudini nettamente opposte a quelle delle proprie radici, ne esistono molti; ma in Caserta non c’è nessuna compiacenza. Egli racconta come se le vicende gli fluissero davanti mentre sta affacciato a un balcone. Può dunque osservare tutto, tutti i particolari di Stoccarda e degli operai italiani che lì vivono, e tutti i particolari di Matera, a cominciare dagli stenti di alcuni, dalle battaglie politiche locali, dai compromessi e dalla sfiducia in una svolta qualsiasi che spinge quindi all’emigrazione.
 Sulla strada di Jesce ha la carica delle tragedie greche, che piombano inaspettate e cancellano ogni cosa o la ribaltano su binari imprevedibili. La leucemia di Elena è come una punizione alla gioia del ragazzo che ha trovato l’amore dopo paure e privazioni; la morte di Francesco nell’incidente stradale è l’imprevedibile che il Fato ha progettato per dare la fine a un percorso che forse avrebbe riaperto un senso nuovo dei rapporti umani e sociali del giovane. Francesco è il corrispettivo della Matera di quel tempo.
Sulla strada di Jesce ha la carica delle tragedie greche, che piombano inaspettate e cancellano ogni cosa o la ribaltano su binari imprevedibili. La leucemia di Elena è come una punizione alla gioia del ragazzo che ha trovato l’amore dopo paure e privazioni; la morte di Francesco nell’incidente stradale è l’imprevedibile che il Fato ha progettato per dare la fine a un percorso che forse avrebbe riaperto un senso nuovo dei rapporti umani e sociali del giovane. Francesco è il corrispettivo della Matera di quel tempo.
Infatti su questa storia d’amore Caserta ha saputo creare attorno un affresco che riesce a dare l’idea esatta di ciò che, all’epoca, avveniva tra lavoro e disoccupazione, desiderio di emergere dalla miseria, progetti di vecchie madri che, con sospiri e preghiere, avrebbero voluto dare corso a una nuova Storia fatta di giustizia e di pace.
Segue un racconto breve intitolato Natale, il ritratto di un padre, fatto attraverso il rituale della nascita del Bambin Gesù in una chiesa; e bisogna dire che è un ritratto a tutto tondo, efficace, in cui le parole dello scrittore diventano pennellate riuscite, linee perfette di una umanità che ormai sembra essersi dispersa.
Un di più è di una tristezza che lascia tracce scomode nell’animo. Storie come quella di Biagino sono esistite e forse esistono in ogni paese, non solo del Sud; ma Caserta ha saputo raccontarla con un garbo che commuove, con una perizia consumata che evita ricorsi al neo-realismo.
La guerra, i tedeschi, le fughe per l’Italia, il ritorno verso casa, i morti seminati dai tedeschi sempre più rabbiosi durante i rastrellamenti, Carlina incinta, Carmela che diventa sposa ma non può generare… Una sequela infinita di avvenimenti concentrati in appena venti pagine, con un ritmo narrativo davvero calibrato e reso con sfumature che riescono a dare la portata di un percorso che sembra essere guidato dal destino e che finisce nella malinconia più acuta. Caserta sa descrivere i drammi e le tragedie con mano felice, farli accadere come necessaria conseguenzialità della logica del racconto. E questo suo procedere la dice lunga sulla conoscenza che ha delle tecniche narrative.
Ma proseguiamo con Via Brennero: “Questo treno è come se portasse i rami secchi della storia: quelli che farebbero fuoco in un qualunque focolare”. Sì, siamo in treno e nello scompartimento c’è “una donna grassa, in pantaloni” e il marito “mingherlino e sdentato”, e naturalmente i bambini al seguito. E c’è lui che guarda, che si mette a pensare ciò che accadde nei campi di concentramento, visto che il treno è diretto in Germania via Brennero, a pensare che il padre è morto, e quindi il paese è meglio cancellarlo. Il padre “non voleva assolutamente che io emigrassi. ‘Sarà la mia morte’ – diceva”… Uno dei racconti più belli del libro, una misura calibrata e densa di allusioni, del ribollio interiore che non dà pace. E Caserta questo ribollio ce lo fa sentire in tutta la sua disperazione…
“Nomina numina, nomina sunt consequentia rerum”! Il destino di Roccuccio Chiancazzo è racchiuso in queste sentenze. E infatti il personaggio se ne convince, anche se da pastore diventa prima sindacalista e poi emigrante in Argentina, a Torino, a Bra. Una vita intera ruotante attorno al buffo nome e cognome, a cominciare dalle elementari, cioè da bambino. I compagni di scuola ridevano di quei suoni che al loro orecchio sembravano sconci, grotteschi e goffi. Roccuccio finisce perfino in carcere dove incontra Rocco Scotellaro (ma l’aveva già incontrato durante un comizio fatto dal poeta al suo paese). E poi finisce sulla sedia a rotelle.
Ancora una volta Caserta riesce a sintetizzare in breve spazio un vero e proprio romanzo, dove appaiono protagonisti di vario genere, in un clima che fa rivivere epoche che sono state quasi mitiche nel bene e nel male. Si pensi a che cosa rappresentò Eva Peron in Argentina e il poeta di Tricarico in Basilicata.
Un uomo fa pensare a certe figure deleddiane. Ritorna (c’è notizia quasi in ognuno dei racconti) l’occupazione delle terre, l’emigrazione in terre lontane e ritorna il panorama di una Basilicata che non è fatta soltanto di calanchi e di Murgia, ma soprattutto di persone. “Terra di mamme grasse, di padri lustri e scuri come scheletri”, come scrive Leonardo Sinisgalli, terra che radica gli uomini con radici salde anche quando il terreno è sterile e roccioso.
Il racconto seguente, Muore giovane chi al cielo è caro, famoso verso di Menandro utilizzato anche da Leopardi, esula un poco dalle tematiche degli altri, è spostato più sulle idee e sulle condizioni del vivere, e non è dunque casuale che la moglie del narrante commenti: “Al solito, e siamo arrivati alla filosofia”. Generoso il giudizio sulla Calabria: “… per andare a respirare… un po’ di quell’aria marina calabrese, della quale nessuna è più gradita”. Non nascondo che ho pensato che il riferimento sia a Roseto Capo Spulico.
Belle le lettere di Bellisario alla madre, e stringato ed essenziale il dettato, in Pro patria mori, ancora un ritratto ben riuscito, in cui i particolari guicciardiniani contano più del dovuto. Ma altrettanto bello il racconto intitolato Suor Angelica, una strana storia che si svolge in ospedale con un Roccantonio stupido e avventuriero inizialmente, e poi prodigiosamente piegato su se stesso dopo le avances fatte alla suora in una notte davvero priva di senso. Il passato di Suor Angelica era stato tenebroso, aveva subito una violenza “nel capanno dell’orto, in un lontano paese della Calabria sulle rive del mar Ionio”.
Tutto ci si poteva aspettare da un personaggio gretto e rozzo, tranne che il comportamento di Suor Angelica lo portasse alla conversione; ma l’insistenza di Caserta nel colorire quasi con foga i particolari dell’erotismo del protagonista qualche sospetto lo crea e dunque ancora una volta lo scrittore segue il filo della logica interiore, che lo porta a quella conclusione davvero singolare.
Sotto l’aura di Orazio Giovanni Caserta scrive Un monumento per il padre,che ha tutta l’aria di non essere una invenzione, ma rispetta l’affermazione che egli ha fatto all’inizio del libro: “Volessero sapere [i lettori] se i miei personaggi sono veri, direi loro che sono tutti veri, anche quando non sono mai esistiti”. Si tratta di una vera e propria elegia, anzi una sorta di canto funebre di antichissimo conio, di quelli che un tempo avvenivano davanti al defunto, raccontando gli episodi più importanti della sua vita, ricordando la sua generosità, le sue fatiche, i sacrifici, l’amore profuso ai familiari e agli amici.
Commovente la chiusa del racconto che sembra il sigillo per la gloria paterna:
“Nel tempo, del resto, tutto diventa piccolo, perché tutto diventa lontano. Anche i monumenti di bronzo finiscono [altro riferimento colto]. Ti ho voluto solo dire, da morto, e quando non mi puoi ascoltare, quello che io ho sentito e sento per te. Se te l’avessi detto quando eri vivo, non mi avresti ascoltato e, facendo un segno con la mano, quasi volessi scacciare un fastidioso insetto che ti ronzava sul viso, mi avresti fatto capire che non era il caso. Tutto apparteneva alla legge della vita, quando la vita si prende sul serio. E tu l’avevi presa sul serio”.
Negli anni Settanta, per la rivista “Il Policordo” da me diretta, feci un’inchiesta sul racconto, intitolandola “Perché il racconto”. Tra i molti intervistati ci furono Giuseppe Pontiggia e Piero Chiara. Quest’ultimo, con la sua solita franchezza e chiarezza affermò che scrivere un racconto è molto più difficile e arduo che scrivere un romanzo o una poesia. Ma chi si è abbeverato ai classici conosce la misura e sa quando deve fermarsi, quando deve accelerare, deve delineare con maggiore forza una vicenda o il carattere di un personaggio. Giovanni Caserta con evidenza mostra di essersi educato sui classici e di conoscere le fonti insuperabili della nascita del racconto, dal Novellino al Decamerone, da Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de piccirille del Basile ai racconti di Masuccio Salernitano. Sono allenamenti, come altrimenti chiamarli? Che affinano, che insegnano, che sanno aprire le vie giuste. Ecco perché Lettere provinciali è libro riuscito, con una sua voce riconoscibilissima, con un suo passo antico e modernissimo, che affascina e tiene sospeso il lettore fino all’ultima pagina.
Dante Maffia



